|
LA NOTTE DEI VIGLIETTI
di Paolo Chiaselotti

Sostare con il mouse su parole dialettali, straniere o antiche
6. Gaetano insulta Francesco nella stalla. Maria Gaetana Madorno
Gaetano proseguì il suo cammino fino alla piazza di basso, salendo da dietro
la chiesa di San Giovanni, per poi infilarsi sotto l'arco della torretta della Giudeca
e dirigersi verso Santo Petruzzo, sicuro che avrebbe trovato il cugino Ciccio nella
stalla sotto casa.
Francesco, infatti, era sceso a portar biada alla vettura, così come faceva
sempre, ed essendo in fondo al lungo vano quasi buio non sentì, né
vide entrare Gaetano. Udì invece le sue parole: «A donna Fiorina te
la puoi scordare, se no prima ammazzo mia sorella e poi ammazzo te!» E così
gridando gli si avvicinò minaccioso. Francesco afferrò il forcone,
temendo per un attimo di doverne fare uso per rintuzzare i tentativi di aggressione
del cugino ma questi, dopo avergli ripetuto le minacce e sputato addosso, uscì
dalla stalla.
Le grida avevano richiamato l'attenzione del padre di Ciccio, don Antonio, che si
affacciò chiamando a gran voce il figlio per sapere che cosa stesse accadendo.
Ciccio gli disse di rientrare perché non era successo nulla di grave, solo
parole con Gaetano, il cugino, per la questione dell'inimicizia tra le famiglie.
Il padre gli chiese se fosse andato ancora sotto le finestre di Fiorina e lui rispose
stizzito: «E chi l'ha vista!» continuando a metter biada nella mangiatoia
con rabbia.
«Fiorina, Fiorina, Fiorina» fece il verso con tono di scherno una voce
femminile. Subito dopo una giovane donna sbucò da dietro una balla di fieno
accostandosi a Francesco. «Torna a casa, passo io da te questa sera»
le disse lui continuando a inforcare il fieno senza alzare lo sguardo. Lei si accostò
e cercò di posargli una mano sulla spalla per rabbonirlo.
«Vavattinni, c'unn'è u momentu!»
le disse adirato, mentre lei continuava ad avvicinarsi per accarezzarlo. Francesco,
d'un tratto, come se avesse cambiato umore e idea, con uno slancio improvviso gettò
a terra l'attrezzo che teneva in mano e cercò di afferrarla. La donna fu
pronta ad indietreggiare con un balzo. «Fattela dare da donna Fiorina!»
gli gridò. Non era la prima volta che gli si negava, in altre occasioni lo
faceva per farlo ingelosire, perché aveva il mese, per semplice capriccio.
Questa volta lo fece con il proposito di farlo soffrire, di dimostrargli che era
capace di non soggiacergli.
Da due anni Francesco le aveva messo gli occhi addosso, prima con la scusa di prenderla
in casa come domestica della madre donna Aurelia, poi dicendole che era rimasto
colpito dai suoi occhi, poi facendole qualche piccolo regalo e infine, un giorno
che passò dinanzi la stalla, le chiese se voleva vedere la cavalla che aveva
figliato il giorno prima. E così la prese, lì, e la trattenne, che
non aveva ancora diciotto anni.
Poi cominciò a frequentare la casa di lei, e la madre, grazie alla promessa
di benefici presenti e futuri, accettò che la figlia diventasse l'amante
di don Ciccio. Mentre in Maria Gaetana il desiderio di incontrarlo cresceva di giorno
in giorno, in lui diminuiva la voglia di lei. Gaetana cercava di attrarre Francesco
con leziosità, moine e bronci. «Mi
fa scastà l'arma …» le diceva lui con un certo disprezzo
e poi la copriva senza dire una parola. Solo quando stava raggiungendo l'orgasmo
le prometteva soldi, matrimonio, figli, casa e terre, mentre lei ansimava ad ogni
promessa, conscia che da lì a poco tutto di lui sarebbe finito in quel buco
senza memoria.
Gaetana si avviò verso l'uscita, mentre Francesco temendo qualche
spaparanzata cercò di trattenerla: «Ninuzza, aspetta!»,
ma la giovane, data una rapida occhiata fuori dalla porta, corse verso casa.
«'Ncul'a ttia e a mammita!!»
le gridò Francesco.
«A ttia, e a mammita!» lo ricambiò
lei girandosi un istante.
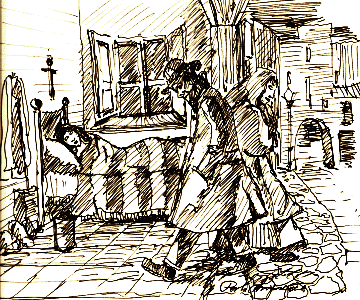 Francesco si era pentito - nel senso peggiore della parola - di quella relazione
che durava ormai da tempo, e finanche della compiacenza della madre che usciva da
casa ogni qualvolta lui vi entrava, per farvi ritorno dopo un'ora, a rapporto consumato.
Lo sapevano tutti che Gaetana Madorno faceva commercio illecito con don Ciccio,
e quando la notte vedevano Maria Francesca Ferace girovagare per i vicoli, strizzando
l'occhio commentavano: «Mamma escia e
Cicciu trasa!»
Francesco si era pentito - nel senso peggiore della parola - di quella relazione
che durava ormai da tempo, e finanche della compiacenza della madre che usciva da
casa ogni qualvolta lui vi entrava, per farvi ritorno dopo un'ora, a rapporto consumato.
Lo sapevano tutti che Gaetana Madorno faceva commercio illecito con don Ciccio,
e quando la notte vedevano Maria Francesca Ferace girovagare per i vicoli, strizzando
l'occhio commentavano: «Mamma escia e
Cicciu trasa!»
Maria Francesca faceva finta di niente, come se quelle passeggiate con pioggia o
vento fossero la cosa più naturale di questo mondo per una vedova di trentasei
anni! Per evitare, però, che si facessero cattivi pensieri anche su di lei,
si teneva lontana dalle case di conoscenti, amici e parenti. Nelle sue camminate
forzate incontrava o vedeva persone, anche senza essere vista. In una di queste
circostanze le capitò di vedere il cugino di don Ciccio, don Gaetano, in
compagnia di Vincenzo, il galiuoto, appostati prima
nel vico Puzzillo, dopo in un angolo di Santo Pietruzzo, a guardare verso la casa
di don Ciccio. La madre lo disse alla figlia, la quale lo disse al suo amante, il
quale, ridendo, sollevò qualche dubbio su ciò che Maria Francesca
diceva di aver visto.
«Saranno stati due clienti di Cosci 'i
voia» le disse alludendo alla donna che faceva meretricio alcune
case più sotto.
«Guardavano alla casa di Vussuria!»
ribadì Gaetanina a Francesco, il quale continuò, purtroppo, a non
dar peso ai sospetti della madre e alle preoccupazioni della figlia. «Ah, s'avia asuliatu a mamma!»
disse ad una amica alcune ore dopo l'ultimo incontro con l'amante.
7. A casa De Chiara
Don Luigi uscì per andarsi a bere un bicchiere di citrata
magnesia da don Eugenio, e anche per cercare di saperne di più
sulle indagini del sindaco sulle loro drude, la sua,
Catarineddra, e la magara di
suttalarco, come lui chiamava con disprezzo l'amante del fratello.
«Ma da quando in qua un sindaco si occupa di femmine gravide?» si chiedeva
passando sotto casa Campolongo, mentre ricominciava a nevicare. Giunto alla spezieria,
chiese innanzitutto a don Eugenio se avesse visto il proprio fratello Gaetano, poi,
dopo aver bevuto il bicchiere di magnesia ed aver emesso alcuni rutti che egli definiva
salutari per il corpo e per lo spirito, propose allo speziale di accompagnarlo a
casa De Chiara, dov'era consuetudine ritrovarsi per dirimere beghe. O crearne di
nuove.
Don Luigi sperava di incontrare lì, luogo di galantuomini, qualcuno che lo
informasse sulle indagini del sindaco e se fosse vero che l'occulto suggeritore
dell'informativa fosse suo cugino Ciccio.
Attraversarono la piazza e giunsero dinanzi all'ingresso di casa De Chiara. Don
Diego, buonanima, dopo che erano state tolte le ultime rovine dell'ospedale dei
poveri attaccato alla sua casa, aveva fatto restaurare il portale e la facciata.
Don Luigi, che non riusciva né voleva nascondere i sentimenti di invidia
che provava dinanzi al benestare altrui, disse a
don Eugenio che un giorno, alla morte del padre, avrebbe rifatto la facciata della
casa, cento volte migliore di questa che gli pareva meschina, solo che don Gaspare,
il sindaco, gli doveva togliere quella vecchia porta della città che gli
rovinava il prospetto.
Mentre era intento a spiegare i suoi progetti, venne ad aprire il portone don Pasquale,
il sacerdote, che con i suoi modi gentili e aggraziati diede il 'buonivenuti', ricambiato
dal 'buonotrovato' degli ospiti. Don Luigi, mentre salivano le scale verso il piano
superiore, non mancò di far notare all'amico, toccandolo con il gomito, le
calze di lana fine che si intravedevano sotto la tonaca del prete, sorrette da due
taccaglie sotto il ginocchio. I modi garbati e gentili
di don Pasquale De Chiara e certe sue raffinatezze erano per don Luigi la certezza
che fosse ricchione, ma non avendone alcuna prova,
aveva ritenuto giusto inventarne qualcuna e diffonderla nei conviti con gli amici.
Al piano superiore trovarono un altro sacerdote, don Domenico Talarico. Alcuni fogli
di appunti sul tavolo, una focaccina colle alici e due bicchieri di vino bianco
di Tocco, erano le tracce di una piacevole discussione appena interrotta. I due
nuovi arrivati furono invitati ad accomodarsi e ad assaggiare quel che era in tavola,
che presto avrebbero avuto il vino e, se ne gradivano, un'altra focaccia.
Stavano leggendo alcune poesie del giovane Candela. «Bella testa che Dio gli
dia vita e ispirazione» disse don Pasquale, e don Domenico aggiunse che pochi
ce n'erano come lui che a soli ventitre anni erano entrati nella cerchia dei più
dotti galantuomini della provincia. Don Luigi pensò tra sé che doveva
essere ricchione anche lui, il giovane s'intende, che di don Domenico non aveva
alcuna considerazione. Finse di compiacersi anch'egli della fortuna che avevano
donna Margherita, la madre e donna Marianna, la sorella, di tenere in casa questo
geniale frutto della capitale. Il tono eccessivamente enfatico e le parole pronunciate
masticando tradivano i reali sentimenti del canonico che non tentava, neppur per
rispetto all'ospitalità, di mascherare.
I nomi delle due donne accostate a quel velato accenno di nascita nella capitale
del regno avevano il sapore di un'ingiuria, anche perché era noto che in
casa di don Luigi e in casa di don Eugenio circolavano idee politiche diverse da
quelle che circolavano in casa De Chiara, o almeno di quelle che don Pasquale, moderato
e amante del quieto vivere, non condivideva.
La Costituzione, che già nel 1821 aveva diviso gli animi, le amicizie e finanche
le famiglie, era nuovamente sulla bocca di tutti: di coloro che speravano che fosse
promulgata e degli altri che la consideravano fonte di disordine sociale. I giovani,
in genere, erano esuberanti e smaniosi di vedere novità, gli anziani a cominciare
dai genitori erano più prudenti e timorosi di perdere ciò che possedevano.
Le parole si sprecavano, assieme al tempo e al vino, nelle lunghe tavolate.
Forse l'accenno al nome Marianna o forse il fatto che si fossero nominate due gentildonne,
in una riunione di canonici, fece scivolare il discorso sulla morale femminile e
in particolare sulle donne prossime a partorire. E per restituire pan per focaccia
il mite don Pasquale esordì dicendo che spesso, troppo spesso, le donne di
servizio restavano gravide.
«Chissà perché, forse per il troppo affetto dei loro giovani
padroni.» L'accenno garbato e malizioso fece sorridere lo stesso don Pasquale,
don Domenico e don Eugenio, ma non il canonico Cristofaro che non apprezzò
affatto le allusioni del correligioso.
Si trattenne però dal reagire come avrebbe voluto. In altra occasione e con
qualche bicchiere in più la sua mano sarebbe corsa nella tasca in cui portava
il coltello inguainato; oggi la cosa a cui teneva di più era sapere chi avesse
indotto don Gaspare a prendere le misure precauzionali per impedire che i prossimi
nascituri fossero proietti. Non tutti quelli
che sarebbero nati ma solo quelli di Catarineddra, la sua serva, e della magara
di suttalarcu. La tensione si stemperò con l'arrivo di altre focacce di grano
indiano con alici salate e di due brocche di vino rosso di Piparo.
Don Luigi, visto che il mangiare e il bere avevano ben disposto l'animo dei presenti
ad una sempre maggiore loquacità, suggerì di estendere la conversazione
ad altri galantuomini ben pensanti, e fece i nomi del capo brigata don Giovanni
Annicchiarico, dei fratelli Campolongo, del dottor Luigi Sarpi e del proprio fratello
Gaetano.
La loro influenza e l'amicizia con il sindaco avrebbero potuto sistemare una questione
che rischiava di esasperare ancor più l'astio tra due famiglie, oltre che
far diventare ciò che da sempre era uno sfogo all'esuberanza maschile un
riconoscimento di paternità.
«Già le case erano invase da serve e muli di padre incerto»
ragionò don Luigi «se poi di ogni nato per impudicizia della madre
se ne devono occupare anche i preti addio religione!»
Don Pasquale De Chiara, forse di malavoglia ma certo per non apparire avaro, fu
il primo ad approvare l'idea del convivio e diede ordine al servo Filippo di andare
a chiamare le sunnominate persone e di far portare in tavola altre focacce e vino
per i nuovi invitati.
Giacomo e Vincenzo Campolongo che abitavano all'altro lato della piazza giunsero
per primi, seguiti da don Luigi Sarpi e, dopo una mezz'ora circa, da Giovanni Annicchiarico,
che si scusò del ritardo per aver dovuto disporre i turni di guardia per
la notte. Gaetano arrivò più tardi, un po' alterato ma comunque consapevole
che tutte quelle persone potevano sempre essere utili per aiutarlo ad uscire impunito
dalle innumerevoli sbirrate alle quali sovente si abbandonava.
I fratelli Campolongo si erano seduti a lato di don Luigi, don Gaetano si trovò
accanto il sottufficiale e il dottore Sarpi si sedette tra il padrone di casa e
il sacerdote Talarico. Dai vetri appannati dal calore della stanza si intravedevano
le case Candela, Campolongo, Aiello e, immerse già nella nebbia e nell'incipiente
oscurità, le sagome di Castrocucco e Bocita.
Don Domenico, come se l'argomento del colloquio precedente non si fosse mai interrotto,
continuò il suo ragionamento sull'abbandono dei figli da parte di madri snaturate.
I nuovi arrivati, ben sapendo che una tal questione riguardava proprio i fratelli
Luigi e Gaetano, lì presenti, ed essendo al corrente della decisione del
sindaco don Gaspare di contrastare gli abbandoni, non mostrarono interesse alcuno
ad intervenire. Solo don Giovanni si introdusse nel discorso, affermando che la
questione non era solo morale ma da un punto di vista economico era di grave pregiudizio
per le povere casse comunali, oberate di spese di
baliatico, per non parlare della provvisione a suor Crocifissa e alla
casa dei proietti. Ben faceva il sindaco ad avvertire le gravide che erano serve
in questa o quella famiglia, e i loro padroni, a dar conto delle nascite.
Don Luigi non mise neppure questa volta la mano in tasca, anzi posò bene
in mostra entrambe le mani tamburellando con le dita sul tavolo e, come a voler
richiamare don Pasquale al suo dovere di anfitrione, disse scherzosamente che le
alici stavano prendendo il largo!
Tutti risero e così l'argomento fu interrotto; ciascuno allungò la
mano verso una novella porzione di focaccia e un bicchiere di vino. Mangiando e
intruzzando i bicchieri
furono fatti gli onori a casa De Chiara e ai suoi ospiti.
 Don Pasquale, con un'apparente aria di compiacimento per la presenza di tanti amici,
versò più volte il vino e quando, giunto al posto del canonico don
Luigi, ne versò quel poco che era rimasto nella brocca, si sentì da
questi apostrofare: «Don Pascà, non devo fare un figlio prete!»
Don Pasquale, con un'apparente aria di compiacimento per la presenza di tanti amici,
versò più volte il vino e quando, giunto al posto del canonico don
Luigi, ne versò quel poco che era rimasto nella brocca, si sentì da
questi apostrofare: «Don Pascà, non devo fare un figlio prete!»
L'espressione, usata scherzosamente ogni qualvolta il bicchiere non veniva riempito,
in altra circostanza avrebbe fatto ridere ma in quell'occasione produsse tutt'altro
effetto: un silenzio così corposo da fare sentire la neve che cadeva, mentre
la mano di don Pasquale posava lentamente la brocca dinanzi il bicchiere pieno a
metà.
«Ve ne faccio portare subito una brocca piena, se questo vi potrà aiutare
a non fare figli preti e, soprattutto, a non farne del tutto visto che siete un
sacerdote» disse l'ospite di casa scandendo le parole, con voce ferma ma senza
alcun tono di riprovazione per quel che aveva udito.
La mano di don Luigi scivolò lentamente dal tavolo verso la tasca e qui si
fermò. Gli occhi freddi e severi del brigadiere puntati su di lui lo fecero
desistere dal commettere un'azione di cui si sarebbe pentito con la testa in ordine.
Gaetano, persuaso come sempre che ognuno poteva fare e dire ciò che meglio
gradiva, e per superare in spavalderia il fratello Luigi, si alzò e disse
con la voce impastata: «I bicchieri si empiono e si votano, come le femmine,
e se non si vogliono riempire, queste si votano, così non nascono figli ma
forse nascono i preti!»
Senza pensare che tra i preti presenti ci fosse anche suo fratello Luigi, anch'egli
prossimo padre di figlio illegittimo, Gaetano disse che la misura era colma e che
i falsi moralisti erano solo spioni e infami, come suo cugino Francesco che aveva
suggerito al sindaco di avvertire due, dico, due sole donne incinte di questo paese
a dar conto del parto! «Una vorpigliata con
i cazzi ci voleva a quel merdo» continuò Gaetano «da lasciarlo
un poco vivo, e non morto, per fargli una seconda e una terza
vorpigliata!»
Lo stupore che il suo dire provocò sui presenti fu doppio: i sacerdoti si
sentirono insultati da quella blasfema allusione al modo diabolico di concepire,
il brigadiere e il dottore scorsero nelle ultime parole la premeditazione di un
delitto.
Due sacerdoti si fecero il segno della croce, il terzo si alzò e disse al
fratello di tacere che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e non sapeva quello
che diceva.
Il capo delle guardie regie disse a don Luigi di tenerlo ben a freno, perché
non era la prima volta che faceva di questi discorsi e profferiva minacce, e che
lo aveva già fatto in sua presenza nella spezieria
di don Eugenio Romita qualche mese prima. Se avesse saputo che c'erano i due fratelli
Cristofaro egli non sarebbe neppure salito e comunque ringraziava don Pasquale De
Chiara per la sua cortesia e per l'ospitalità ma doveva congedarsi.
Don Luigi lo fermò appoggiandogli una mano sul petto. Volse per un istante
lo sguardo su Gaetano, seduto e corrucciato, poi sollevò gli occhi al cielo
e disse: «Dio mi è testimone se mai feci del male, e in quanto a mio
fratello si sa che nei giovani la testa e il corpo hanno i bollori, soprattutto
quando l'accusa non è provata. La sua druda è
donna di mestiere e il figlio può essere di tutti. Se il
baliatico è pagato per gli altri lo sarà anche per il figlio
di questa donna. In quanto a me» proseguì «nella
mia casa abbiamo a cuore la sorte di una povera serva che esce per lavare i panni
e per le imbasciate, e che uscendo non
sappiamo chi dove e quando può averla ingravidata. Le persone che ti odiano,
come anche i miei cugini, che siamo in causa come tutti sanno, non ci mettono tanto
a dire che Catarineddra è la mia druda ma io
nella confessione mi ha detto chi è veramente il padre del figlio che porta
in grembo!» e mentre tutti attendevano il nome del padre naturale chiuse solennemente
con queste ultime parole: «Che io non posso rivelare per il segreto della
confessione».
Per tutto il tempo don Luigi tenne la mano e gli occhi addosso al brigadiere, sapendo
che lo avrebbe convinto a restare. Quindi, cambiando teatralmente tono e atteggiamento,
invitò tutti a riprendere nell'amore di Dio quel piacevole convivio, «turbato
solo dal diavolo che, come si sa, mette le corna dappertutto per
scristianare la pace familiare!»
«Anzi» proseguì «visto che si avvicina l'ora di cena sono
felice e onorato che tutti i presenti venghino a casa mia a mangiare una porchetta.
E vi farò ricordare il quartordici gennaio del mille ottocento e quarantotto,
che se Dio vuole, e sua Maestà pure, sarà l'anno della Costituzione!»
Don Giovanni declinò per primo l'invito per motivi di servizio e raccomandò
a don Luigi, per il suo bene, di non parlare di cose di là da venire, visto
che sua Maestà, per grazia di Dio, non aveva ancora deciso nulla. Gli altri
due sacerdoti ricordarono al correligioso che era venerdì. «Ne ero
completamente dimentico» rispose il canonico «forse a causa della neve
e del freddo che è tanto che lo stesso Gesù Cristo direbbe esser giusto
non tener conto d'astinenza».
Dal portone De Chiara uscirono a due ore dall'imbrunire don Giovanni Annicchiarico
e don Luigi Sarpi. Si accompagnarono fino avanti le monache dove don Luigi imboccò
la stretta vinella sotto casa Conte, mentre il brigadiere proseguì verso
il posto di guardia alla piazza di sotto. «Stia attento, dottore, a ficcarsi
in quel budello, può fare brutti incontri» gli disse il brigadiere.
«Di che genere?» chiese don Luigi ridendo e continuando a camminare
nel lungo varco buio che portava alla strada del Critè.
L'altro, dopo aver controllato che le grate del convento di fronte fossero prive
di luci, gli gridò «Di amendue i generi!» alludendo a ladri e
prostitute.
Dopo alcuni minuti da casa De Chiara uscirono Giacomo e Salvatore Campolongo, Don
Eugenio Romita, il sacerdote don Luigi, suo fratello Gaetano, tutti diretti a casa
di questi ultimi.
8. A casa Cristofaro per scannare la porchetta da cucinare e in attesa la partita
a carte nella spezieria.
Entrarono dal cancello laterale, imboccando la discesa che conduceva agli interrati
e all'orto. «Eugenio, a vussuria l'onore della scelta» disse don Luigi
indicando i cellai con i maiali. «Scegliete la
porchetta migliore e scannatela pure. Vincenzo vi aiuterà.» Fu scelto
un animale in grado di soddisfare l'appetito di una compagnia ben maggiore di quella
presente. In un attimo fu issato a testa in giù sul
gammello e don Eugenio, con l'aria di un sacerdote pagano, gli vibrò
una coltellata nella gola. Il sangue dell'animale, le sue grida e gli spasimi della
morte erano scene a cui tutti erano abituati, anche gli altri maiali che continuarono
a grufolare nelle loro zimme. Quindi Vincenzo ne accelerò la morte, e a lui
fu affidato il compito di arrostire le carni per il pranzo. Chi raccomandò
il sale, chi il rosmarino, chi soprattutto il vino. Don Luigi diede l'ultimo ordine
al domestico: «Appena la porchetta è pronta ci vieni a chiamare nella
farmacia di don Eugenio». Quindi la compagnia si avviò verso la bottega
dello speziale per la solita partita a carte.
Il farmacista aprì la vetrina della spezieria Conte, all'angolo dell'edificio,
e uno alla volta, superato il bancone, si infilarono nel retrobottega. Si sedettero
al tavolo dove don Eugenio era solito preparare i farmaci, don Luigi aprì
il cassetto che ben conosceva, prese un mazzo di carte e iniziò a mescolarle.
Eugenio fece un salto a casa dietro l'angolo di palazzo Conte per dire al piccolo
domestico Francesco di portare un garrafone di
vino a casa Cristofaro e di attenderlo lì, dando una mano a Vincenzo. Per
non essere da meno anche Giacomino Campolongo volle che sulla tavola non mancasse
il suo vino. Affacciatosi sulla porta fischiò in direzione del palazzo, che
distava pochi metri. Da una porta laterale nel vico delle sore uscì Giuseppe
Pastore, il domestico. Gli bastarono alcuni gesti di don Giacomino per capire ciò
che avrebbe dovuto fare: portare a casa Cristofaro un garrafone
di vino per il consueto convito.
Terminati questi preliminari don Eugenio e don Gaetano rientrarono, e il gioco iniziò
daccapo, con qualche disappunto di don Luigi che stava vincendo.
Quasi nessuno aveva voglia di parlare e, come al solito, i soldi in palio e i continui
inviti al silenzio contribuirono a zittire anche chi avrebbe voluto segnalare qualche
errore di troppo. Le monete sul tavolo andavano e venivano e mentre don Salvatore
Campolongo terziava ogni carta con lentezza esasperante,
Don Gaetano, spazientito, lo invitava a giocare che faceva l'alba. In meno di mezz'ora
quest'ultimo aveva finito quelle poche monete che aveva in tasca, Giacomo Campolongo
le aveva viste crescere e nessuno aveva voglia di continuare fino al debito di gioco.
Solo don Luigi, che negli appetiti di qualsiasi natura tendeva ad essere smodato,
insistette perché Giacomo gli concedesse un'ultima partita.
Un lieve tamburellare sul vetro della porta annunciò l'entrata delle guardie
civiche di turno in quella serata fredda e nebbiosa: Gaetano Marone e Francesco
Dardis, il primo un tintore di Paola, l'altro calzolaio, meglio conosciuto come
Scuppetto, fecero il loro ingresso
in quel circolo di galantuomini.
Furono accolti con un freddo 'buonivenuti', e benché nessuno avesse chiesto
loro il motivo della presenza, ritennero di doversi ugualmente giustificare, dicendo
che il loro locale di guardia era talmente freddo e umido che avevano deciso di
camminare nella neve per riscaldarsi un po'. Il fatto che fossero preposti all'ordine
pubblico, che in quel locale pubblico si giocasse a carte, e per di più d'azzardo,
o comunque a soldi, non impedì a quei bravi signori di continuare la loro
partita e ai due ospiti di assistervi.
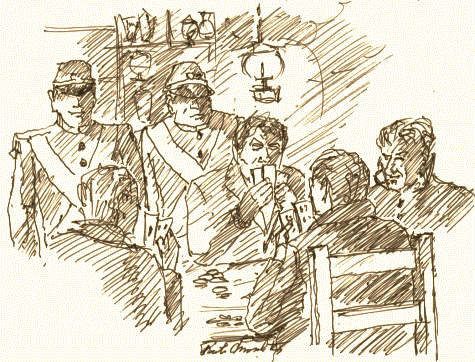 Qualche colpetto di tosse, gli occhi che ruotavano sul soffitto, il pestare lieve
degli stivali sul pavimento per il freddo, erano gli unici segnali della presenza
imbarazzata delle guardie in quel luogo. Un lieve accenno al tepore di quel locale
rispetto all'umidità del loro corpo di guardia fu zittito con un ssssss autoritario
di don Luigi, che finalmente aveva convinto Giacomo a farsi un'ultima mano a mano.
Nessuna remora dimostrarono quei signori nel continuare il gioco con i soldi bene
in vista sul tavolo. «Poiché questi diceva non aver più denari
il don Luigi, il canonico, mettendo le mani in una tasca del calzone ne estrasse
poche monete dicendo essere a sua disposizione non più di quattordici grana,
e quindi trasse fuori dall'altra tasca un lungo stile colla vagina, dicendo che
anche quell'arma era a suo potere oltre alle poche monete che mostrate avea.»
Giunse in quel momento Giuseppe, il giovane domestico di casa Cristofaro per dire
che la porchetta entro poco sarebbe stata portata in tavola. La notizia spense ogni
interesse al gioco e tutti si alzarono per ritornare a casa di don Luigi.
Qualche colpetto di tosse, gli occhi che ruotavano sul soffitto, il pestare lieve
degli stivali sul pavimento per il freddo, erano gli unici segnali della presenza
imbarazzata delle guardie in quel luogo. Un lieve accenno al tepore di quel locale
rispetto all'umidità del loro corpo di guardia fu zittito con un ssssss autoritario
di don Luigi, che finalmente aveva convinto Giacomo a farsi un'ultima mano a mano.
Nessuna remora dimostrarono quei signori nel continuare il gioco con i soldi bene
in vista sul tavolo. «Poiché questi diceva non aver più denari
il don Luigi, il canonico, mettendo le mani in una tasca del calzone ne estrasse
poche monete dicendo essere a sua disposizione non più di quattordici grana,
e quindi trasse fuori dall'altra tasca un lungo stile colla vagina, dicendo che
anche quell'arma era a suo potere oltre alle poche monete che mostrate avea.»
Giunse in quel momento Giuseppe, il giovane domestico di casa Cristofaro per dire
che la porchetta entro poco sarebbe stata portata in tavola. La notizia spense ogni
interesse al gioco e tutti si alzarono per ritornare a casa di don Luigi.
La guardia civica Marone «stimò quell'atto di mostrar l'arma
uno scherzo, per cui non vi fece attenzione alcuna e poiché dopo pochi momenti
la spezieria venne chiusa, anch'egli col Dardis se
ne partirono, prendendo ciascuno la volta della propria abitazione.»
«A me nessuno mi leva dalla testa che dovevamo arrestarlo!» disse Gaetano
Marone al suo capo ronda. «Stai scherzando! A Dolluigi?» rispose arretrando
Francesco Dardis. «E con quale imputazione?»
«Asporto di arma atta ad offendere!» rispose con sussiego la guardia.
«Quale arma?!» «Quella che ha estratto dalla tasca.» «Ma
chi?» «Il canonico don Luigi Cristofalo.» «Ma quando mai!»
«Come, non l'avete vista? Mentre giocava.» «A me è sembrata
una penna, una penna di quelle a serbatoio» «Così lunga?!»
Il dialogo tra i due continuò a lungo finché Gaetano, assalito da
un dubbio, gli chiese: «Scusate, signor Scoppetto, ma non è che siete
ubriaco?» «Sull'attenti guardia Marone! … Come … come
vi permette …». Francesco Dardis non riuscì a finire la frase
che cadde nella neve, procurandosi quell'alibi che il subalterno, grazie a Dio,
gli aveva suggerito.
9. Battaglia a palle di neve al seminario tra i cugini Cristofaro
Mentre altrove si giocava a carte, nel nuovo seminario annesso alla chiesa di San
Francesco di Paola, don Carlo e il cugino don Beniamino si affrontavano assieme
ad altri giovani studenti in una battaglia a palle di neve: realisti contro rivoluzionari.
Questi ultimi sembravano avere la meglio e forse fu questo, e non altro, il motivo
per cui molti dei giovani realisti, abbondantemente ricoperti di neve, passarono
nelle file dei rivoluzionari.
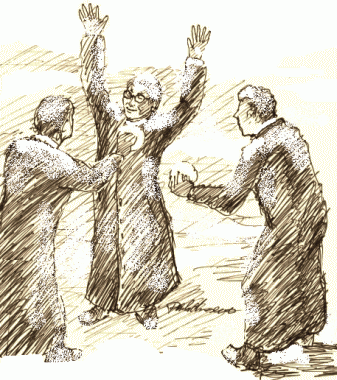 Era rimasto a far la sua parte un terzo cugino, don Salvatore, che nel suo goffo
e impacciato tentativo di unirsi ai rivoltosi inciampò, finendo in mezzo
alla gragnola di colpi che gli arrivarono da entrambe le fazioni.
Era rimasto a far la sua parte un terzo cugino, don Salvatore, che nel suo goffo
e impacciato tentativo di unirsi ai rivoltosi inciampò, finendo in mezzo
alla gragnola di colpi che gli arrivarono da entrambe le fazioni.
Comprese che i salti della quaglia potevan costare cari e ritornò impavido
al suo posto, bersagliato onorevolmente da decine di palle di neve.
Bianco come poteva esserlo solo il papa nel più solenne dei pontificati,
girandosi di spalle gridò: «Viva Pio IX. Amnistia, amnistia!»
A quel nome i piccoli allievi rivoluzionari si fermarono, solo don Carlo lanciò
l'ultima palla, con il messaggio: «Da parte dell'apostolo Giuseppe!»
Ben sapendo che nessuno degli apostoli aveva questo nome, Salvatore comprese che
il cugino si riferiva a quel mangiapreti di Giuseppe Mazzini. Il cielo si riaprì
alla pugna, questa volta giocata corpo a corpo, con mani che buttavano neve in ogni
parte, sul volto, sulla nuca, sulle tonache e dentro di queste. Si sarebbe detto
che tutti erano diventati di parte bianca per il candore della neve che li ricopriva.
Alla fine, sfiniti, proclamarono la tregua. Simili a spettri lasciarono il chiostro
per dirigersi verso la camerata. Salvatore ricordò che se non si fossero
ben puliti e asciugati avrebbero rischiato l'indomani di restare chiusi in camerata
e di non andare a teatro, quel teatro aperto con gridolini di giubilo all'interno
del seminario. I seminaristi erano la speranza di tante ricche famiglie sanmarchesi,
che confidavano negli insegnamenti impartiti loro da precettori colti e preparati
come Candela, Selvaggi, Paladino, Pagano, i quali nonostante la loro giovane età
avevano già maturato esperienze letterarie e divulgative di buon livello.
Dei primi due, e ancor più delle loro idee e frequentazioni, non tutti erano
contenti. Don Michele, ad esempio, il padre di Salvatore, raccomandava sempre al
proprio figliolo di non dare troppo ascolto a quel perditempo di don Vincenzo Selvaggi,
di non leggere i libri messi all'indice, e soprattutto di pregare, di impratichirsi
nelle funzioni religiose e nel latino, che quello era il mestiere che aveva davanti.
Per far nascere qualche timore nel figlio, gli prospettava la possibilità
che rivoluzionari e carbonari - e anche qualche massone, aggiungeva a bassa voce
- potessero sottrarre le terre ai galantuomini e, chessò, spartirsele tra
loro, come avevano fatto i francesi di Muratto.
«Senza le terre di Piparo e di Tocco tu avresti finito di studiare, e di leggere
soprattutto. Io e tua madre andremmo servi presso qualche famiglia», gli diceva
guardandolo negli occhi «perché anche la casa si prenderebbero, e tu
passeresti sotto le finestre vedendovi affacciato un Antonio di Santa Catrina o
una Vicenza del Casalicchio». Don Michele accompagnava le parole con la pantomima
di un padrone curvo sotto il peso della miseria e di due lazzari impunemente affacciati
da casa, i quali dovevano essere gli spauracchi in grado di allontanare definitivamente
Salvatore dai circoli liberali antiborbonici.
I discorsi del padre non facevano presa sul figlio, che sempre più si legava
alle teste calde di quella scuola, tra le quali cominciava a far capolino anche
quella di Carlo. Gli articoli che iniziarono a scrivere sul giornalino «La
Ghirlanda» ne erano la prova.
I tre cugini evitavano accortamente di entrare nelle contese familiari e in modo
particolare Salvatore, ogni qual volta si affrontavano argomenti riguardanti membri
delle due famiglie in lite, deviava i discorsi con qualche celia: «Quando
scriverò un libro su Sammarco - diceva loro ridendo - ci metterò anche
le vostre beghe!» Carlo e Beniamino si stringevano la mano e Salvatore fingeva
di impartir loro una benedizione.
10. La notifica dei biglietti alle due drude incinte

L'abbondante nevicata aveva indotto molte persone a rimanere in casa, ma il messo
comunale Francesco Battaglia recapitò ugualmente un avviso del sindaco, don
Gaspare Valentoni, a Catarineddra, druda di don Luigi
Cristofaro.
Achille Sansosti, servente comunale, circa
alla stessa ora recapitò a Marianna, la druda di Gaetano Cristofaro, nel
tugurio in cui abitava, un altro avviso dello stesso sindaco, scritto dal sostituto
cancelliere Francesco Cristofaro.
Perché abbiano dovuto farlo quel giorno e con quel tempo resterà un
mistero, ma lo fecero, e così tutti seppero che la notte in cui i germani
Cristofaro erano intenti a banchettare con i loro amici «corsero i viglietti con cui si avvertivano le
loro drude di dover dar conto dei parti».
L'avviso di Marianna, analfabeta, fu portato da una sua amica, con molta circospezione,
a casa Cristofaro alla Portavecchia, dove poco tempo prima era stato recapitato
l'altro avviso, diretto a Catarineddra.
Quando donna Pasqualina lesse il contenuto delle due notifiche e i nomi delle destinatarie:
quella di suttalarco, il cui nome neppure voleva
pronunziare, e di Catarineddra, prena di un essere che un giorno avrebbe potuto
chiamarla nonna, si lasciò andare a commenti non proprio benevoli verso il
sindaco, il cognato don Antonio, il nipote Francesco, e ovviamente le due amanti
dei figli.
Si fece promettere da Catarineddra che non avrebbe fatto parola con nessuno di quegli
avvisi e li gettò nel focolare acceso. Forse qualcuno era appostato sul tetto
quando la lingua di fuoco si alzò per un breve istante nel camino, oppure,
fuor di metafora, i due messi ritennero che un fatto così segreto dovesse
avere qualche custode in più, oppure Catarineddra non tenne conto delle raccomandazioni
di donna Pasqualina, oppure chi li aveva compilati aveva diffuso la notizia anzitempo,
oppure fu deciso di propagare la notizia per qualche oscuro motivo. Fatto sta che
quando venne servita la porchetta, giunse a tavola, assieme ad essa, quel boccone
avvelenato. Chi lo portò non si seppe mai, ma la notizia degli avvisi fu
all'origine della violenza che da lì a poco si sarebbe consumata.
|





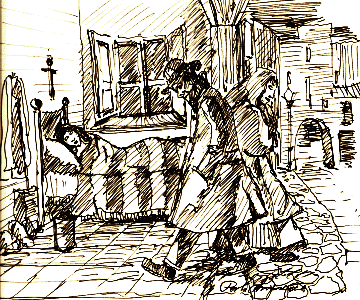 Francesco si era pentito - nel senso peggiore della parola - di quella relazione
che durava ormai da tempo, e finanche della compiacenza della madre che usciva da
casa ogni qualvolta lui vi entrava, per farvi ritorno dopo un'ora, a rapporto consumato.
Lo sapevano tutti che Gaetana Madorno faceva commercio illecito con don Ciccio,
e quando la notte vedevano Maria Francesca Ferace girovagare per i vicoli, strizzando
l'occhio commentavano: «
Francesco si era pentito - nel senso peggiore della parola - di quella relazione
che durava ormai da tempo, e finanche della compiacenza della madre che usciva da
casa ogni qualvolta lui vi entrava, per farvi ritorno dopo un'ora, a rapporto consumato.
Lo sapevano tutti che Gaetana Madorno faceva commercio illecito con don Ciccio,
e quando la notte vedevano Maria Francesca Ferace girovagare per i vicoli, strizzando
l'occhio commentavano: « Don Pasquale, con un'apparente aria di compiacimento per la presenza di tanti amici,
versò più volte il vino e quando, giunto al posto del canonico don
Luigi, ne versò quel poco che era rimasto nella brocca, si sentì da
questi apostrofare: «Don Pascà, non devo fare un figlio prete!»
Don Pasquale, con un'apparente aria di compiacimento per la presenza di tanti amici,
versò più volte il vino e quando, giunto al posto del canonico don
Luigi, ne versò quel poco che era rimasto nella brocca, si sentì da
questi apostrofare: «Don Pascà, non devo fare un figlio prete!»
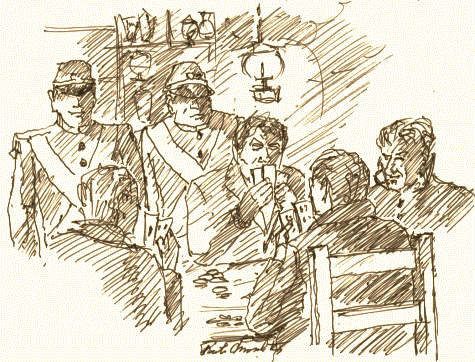 Qualche colpetto di tosse, gli occhi che ruotavano sul soffitto, il pestare lieve
degli stivali sul pavimento per il freddo, erano gli unici segnali della presenza
imbarazzata delle guardie in quel luogo. Un lieve accenno al tepore di quel locale
rispetto all'umidità del loro corpo di guardia fu zittito con un ssssss autoritario
di don Luigi, che finalmente aveva convinto Giacomo a farsi un'ultima mano a mano.
Nessuna remora dimostrarono quei signori nel continuare il gioco con i soldi bene
in vista sul tavolo. «Poiché questi diceva non aver più denari
il don Luigi, il canonico, mettendo le mani in una tasca del calzone ne estrasse
poche monete dicendo essere a sua disposizione non più di quattordici grana,
e quindi trasse fuori dall'altra tasca un lungo stile colla vagina, dicendo che
anche quell'arma era a suo potere oltre alle poche monete che mostrate avea.»
Giunse in quel momento Giuseppe, il giovane domestico di casa Cristofaro per dire
che la porchetta entro poco sarebbe stata portata in tavola. La notizia spense ogni
interesse al gioco e tutti si alzarono per ritornare a casa di don Luigi.
Qualche colpetto di tosse, gli occhi che ruotavano sul soffitto, il pestare lieve
degli stivali sul pavimento per il freddo, erano gli unici segnali della presenza
imbarazzata delle guardie in quel luogo. Un lieve accenno al tepore di quel locale
rispetto all'umidità del loro corpo di guardia fu zittito con un ssssss autoritario
di don Luigi, che finalmente aveva convinto Giacomo a farsi un'ultima mano a mano.
Nessuna remora dimostrarono quei signori nel continuare il gioco con i soldi bene
in vista sul tavolo. «Poiché questi diceva non aver più denari
il don Luigi, il canonico, mettendo le mani in una tasca del calzone ne estrasse
poche monete dicendo essere a sua disposizione non più di quattordici grana,
e quindi trasse fuori dall'altra tasca un lungo stile colla vagina, dicendo che
anche quell'arma era a suo potere oltre alle poche monete che mostrate avea.»
Giunse in quel momento Giuseppe, il giovane domestico di casa Cristofaro per dire
che la porchetta entro poco sarebbe stata portata in tavola. La notizia spense ogni
interesse al gioco e tutti si alzarono per ritornare a casa di don Luigi.
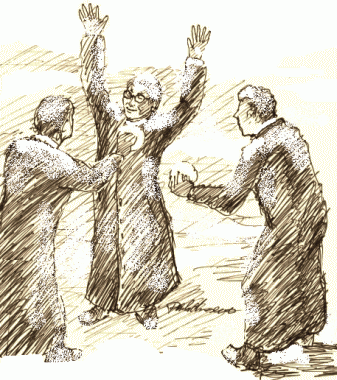 Era rimasto a far la sua parte un terzo cugino, don Salvatore, che nel suo goffo
e impacciato tentativo di unirsi ai rivoltosi inciampò, finendo in mezzo
alla gragnola di colpi che gli arrivarono da entrambe le fazioni.
Era rimasto a far la sua parte un terzo cugino, don Salvatore, che nel suo goffo
e impacciato tentativo di unirsi ai rivoltosi inciampò, finendo in mezzo
alla gragnola di colpi che gli arrivarono da entrambe le fazioni.