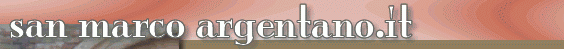 
| |
 San Marco Argentano e i suoi monumenti San Marco Argentano e i suoi monumenti
Vedi anche San Marco su Wikipedia Formato foto 1200 x 900 | |
 |
La Torre (XIII-XIV sec.) Tradizionalmente attribuita a Roberto il Guiscardo, sulla base di un'erronea interpretazione del termine castrum Sancti Marci, la residenza territoriale da lui scelta, fu costruita probabilmente dai Sanseverino, come attestano tre stemmi posti sulla superficie esterna del torrione, al cui interno una scala elicoidale realizzata nello spessore del muro perimetrale consente l'accesso ai quattro vani. Un vano sotterraneo è raggiungibile attraverso una botola ricavata nell'ultima stanza. Attraverso un ponte sospeso, si accede nella stanza mediana del torrione, coperta da una suggestiva volta a padiglione. Illuminata da due ampie finestre ad arco, con funzione di posti di osservazione, è dotata, come le due stanze superiori, di una 'latrina', di una nicchia di accesso al piano inferiore, di un ampio camino. La stanza superiore ha conservato le aperture originarie, di forma rettangolare e di dimensioni ridotte, anch'esse con funzione di avvistamento. L'ultima stanza, di maggiore altezza, riceve luce da una terza finestra posta a livello della copertura. Le due luci, anch'esse predisposte all'avvistamento, sono quelle originarie. Un forno, forse di fattura posteriore, e la solita 'latrina' completano i vuoti praticati nei muri perimetrali. Dal terrazzo si può ammirare il panorama e la valle del Fullone. L'apparente coronamento è in realtà la parte residuale del parapetto difensivo con funzioni di caditoie, di cui sono rimasti solo i beccatelli, ovvero le mensole di sostegno. Il torrione poggia su una piattaforma tronco-conica, in parte circondata da un muro di difesa, che prende il nome di rivellino. Vi si accede attraverso una torretta di guardia a pianta rettangolare, collegata ad una scala attraverso un ponte sospeso, in origine levatoio. All'esterno, ai piedi del rivellino, un'apertura fungeva da via di fuga. |
 |
L'Abbazia di Santa Maria e la Sala Capitolare
della Matina (XI-XIII sec.) Se la torre ha un valore simbolico, l'abbazia della Matina rappresenta il monumento storico per eccellenza della città di San Marco Argentano. Nacque come abbazia benedettina per volere di Roberto il Guiscardo e della moglie Sichelgaita e fu in seguito trasformata in abbazia cistercense di cui ancora oggi conserva la sua principale struttura architettonica: la sala capitolare. Fu grazie alla pubblicazione delle cosiddette Carte Latine dello storico Alessandro Pratesi negli anni Cinquanta del secolo scorso che i preziosi documenti riguardanti la fondazione del complesso monastico divennero il fulcro delle conoscenze storiche riguardanti San Marco Argentano. Le origini stesse della città trovarono in detti documenti conferma del passaggio dalla giurisdizione del vescovo di Malvito al dominio assoluto di Roberto d'Altavilla, che ne comprò titoli e diritti, cedendo buona parte dei territori alla comunità monastica benedettina. Ciò che oggi il visitatore può ammirare è soprattutto l'aula capitolare, che richiamandosi allo stile gotico-cistercense delle abbazia di Fossanova e Casamari, mostra l'originalità di alcune soluzioni stilistico-strutturali, quali le colonne a fascio da cui si dipartono a calice i vari costoloni a sostegno delle suggestive e leggerissime volte. Il complesso edilizio, che conserva alcune strutture originarie, nell'Ottocento fu trasformato in palazzo privato dai baroni Valentoni, i cui eredi sono gli attuali proprietari. |
 |
Convento e chiesa della Riforma (XIV sec - XVIII interno chiesa) Si vuole che sia stato fondato da Pietro Cathin, seguace di San Francesco d'Assisi, ma in verità la costruzione del convento iniziò nel 1320 come attesta un'epigrafe all'interno del chiostro e come è affermato dallo storico francescano irlandese Luke Weddings, italianizzato in Luca Waddingo, nella sua opera "Annales Minorum: seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum". L'opera fu realizzata come atto di devozione da parte della città. Il corpo avanzato della chiesa, dedicata a Sant'Antonio di Padova, fu realizzato probabilmente nel Cinquecento ed era privo dei due ampi finestroni laterali. Nel XVIII secolo le originarie strutture gotiche all'interno furono ricoperte con stucchi e decorazioni di stile barocco. Al suo interno presso ogni altarino sono esposte tele raffiguranti per la maggior parte santi dell'ordine minoritico. Ai lati dell'altare si trovano due tele raffiguranti Pietro e Paolo, opere del pittore Pietro Negroni, nato a San Marco nel quartiere Trivolisi; dello stesso autore è la Trinità posta in alto nella parte absidale. Sotto di essa un crocifisso ligneo attribuito alla scuola di frate Umile da Petralia. Una serie di stalli intarsiati e intagliati datati 1772 e un leggio girevole del 1564 con intarsi su entrambi i lati impreziosiscono la zona retrostante l'altare destinata al coro. La sacrestia custodisce un mobile del Settecento finemente intagliato con motivi naturalistici. Il convento ospitò per un anno Francesco da Paola, che ancora tredicenne fu mandato qui per adempiere ad un voto, svolgendo le funzioni di famulo a servizio dei monaci. A questo periodo gli si attribuiscono i suoi primi due miracoli. Nel giardino del convento, oggi parco comunale, si trova la cappelletta a lui dedicata con la grotta presso cui si recava quotidianamente a pregare. Il nome Riforma dato al complesso si riferisce alla nuova regola monastica da cui i frati minori riformati presero il nome. |
 
|
La Cattedrale (ricostruita XX sec.) e la 'Cripta'(sostrazione XII sec.)
La cattedrale come oggi appare fu relizzata negli anni Trenta-Quaranta del secolo scorso sulla scia di quell'Eclettismo che dettava ancora 'legge' nell'accostamento di stili diversi. Lo confermano i richiami ad architetture toscane del campanile, il portale centrale strombato con arco a sesto acuto affiancato da due piccoli portali 'romanici', sormontato da un vistoso rosone, tutti in pietra da taglio, all'interno le volte stellate di suggestione assisiate, per concludere con le tre absidi circolari decorate all'esterno con chiara ispirazione arabo-normanna. Una stampa di inizi Settecento dell'abate Pacichelli su disegno di Cassiano da Silva mostra qual era il duomo prima della sua demolizione e ricostruzione: la torre campanaria separata dal corpo della chiesa e due enormi cupole che sovrastavano il colmo della navata centrale ai lati nella parte posteriore, sorrette da due torri circolari. Il duomo è dedicato a San Nicola e la sua datazione risale con molta probabilità a fine XII inizi XIII secolo, quando la vecchia chiesa di San Nicola di cui abbiamo testimonianza nei documenti riguardanti l'abbazia della Matina fu ampliata attraverso la realizzazione di un nuovo piano di appoggio, la cosiddetta cripta. Questa costruzione, a lungo ritenuta una cripta, da studi recenti si è rivelata un interessante esempio di struttura di appoggio, che fu realizzata con possenti arcate che l'alternanza di pietra e cotto rende agili e cromaticamente preziose. Quando San Marco subentrò a Malvito come nuova sede vescovile si volle realizzare un complesso che dall'alto della grande silica su cui sorgeva potesse apparire in tutta la sua maestosità a quanti si accingevano a fare il loro ingresso nella città normanna. |
 |
Chiesa di San Marco Evangelista Nonostante la sua importanza, trattandosi della chiesa dedicata al patrono della città la sua storia nel contesto religioso diventa quasi secondaria e senz'altro molto tarda rispetto ad altri edifici religiosi. La sua costruzione risale ai primi anni del Settecento, anche se il culto del Santo era praticato fin dal Cinquecento come attesta la Relazione ad Limina del 1590 del vescovo Antonio Migliori. La Cronistoria riporta che il tempio fu costruito sul luogo dove sorgeva una piccola cappella dell'Epifania, fuori le mura della città, nell'area sottostante la torre. La pianta centrale del nuovo tempio probabilmente ricalca quella della chiesetta, di probabile origine bizantina e, stando alla sua dedicazione all'Epifania, con funzione principale di battistero. Nell'Ottocento la chiesa fu sconsacrata per un certo periodo e fu utilizzata finanche per le riunioni della loggia massonica nata a San Marco dopo la Repubblica Partenopea. Fu in seguito restaurata con un rifacimento della facciata e l'inserimento di nicchie e di elementi decorativi prima dall'arcidiacono Campagna e nel Novecento dal parroco Raffaele Rocco. Caratteristico il campanile posto al centro sul culmine della facciata, ricoperto da una vistosa cupola con maioliche gialle e verdi. Sulla volta una tela del pittore napoletano Luigi De Nicola (1765-1846) raffigura il battesimo impartito dall'Evangelista Marco a Dominata e i suoi tre figli Senatore, Cassiodoro, Viatore, che secondo una leggenda furono convertiti al cristianesimo quando l'Evangelista transitò per San Marco. |
 
|
La fontana di Santomarco (XVIII secolo)
restaurata e rinominata di Sichelgaita nel 1979 La fontana di Santomarco come appare oggi è il risultato di un restauro dello scultore Eduardo Bruno, nato a San Marco e attivo in Toscana, nel 1979. La fontana originariamente aveva la parte superiore che si concludeva con una struttura di coronamento curvilinea, sotto la quale si trovava, racchiusa entro due volute, l'altorilievo in pietra raffigurante il simbolo di San Marco Evangelista, tuttora presente. L'aspetto baroccheggiante del colmo sembrava un'aggiunta postuma al resto dell'architettura, caratterizzata dalla linearità delle lesene e della trabeazione, adorna di tre protomi femminili. Lo scultore decise di ricondurre il tutto ad un prospetto rinascimentale, eliminando la parte curvilinea e ricavandone l'attuale forma rettangolare. L'unico materiale di un certo pregio era quello lapideo limitato alle protomi, all'altorilievo e in parte alle lesene; tutto il resto era cemento e malta cementizia. La vasca fu rifatta in pietra da taglio sagomata, le pareti intonacate tra le lesene furono ricoperte anch'esse con lastre in pietra di San Lucido, la vasca laterale, un abbeveratoio, rimodellata a sedile con pietre ricavate da lastricati dismessi. Le bocche di uscita dell'acqua, semplici fori nella parete, furono abbellite da lastroni in rilievo della predetta pietra e protomi leonine in ghisa nera. Successivamente due delle tre teste muliebri che decoravano la trabeazione, probabilmente con funzione apotropaica, furono dallo stesso scultore attribuite a Sichelgaita (la figura a sinistra) e ad Alberada (quella a destra); quella centrale alla Virtù, il tutto non su base documentale, ma per un semplice accostamento di due figure femminili, abbigliate in maniera 'regale', alle mogli del Guiscardo. Alberada fu appellata la Smorfiosa perché in apparenza sembrerebbe mostrare la lingua. La fontana originaria, i cui lavori di ripristino e costruzione di una condotta sono ampiamente documentati negli archivi comunali tra le opere eseguite dalle varie amministrazioni comunali nel corso dell'Ottocento, cambiò aspetto e denominazione. Da fontana di Santomarco, come era conosciuta dalla sua nascita, fu rinominata fontana di Sichelgaita. Lungi dall'essere una fontana normanna come riportato impropriamente nel cartello segnaletico, a che epoca si può far risalire la sua costruzione? Considerato che i lavori di ripristino e di realizzazione di una nuova condotta risalgono agli inizi dell'Ottocento, essa doveva essere già esistente nel secolo precedente, ovvero nel Settecento, anno in cui è documentata la costruzione della chiesa di San Marco Evangelista. Tuttavia essa non risulta esistere nel XVII secolo, e precisamente nel 1632, in base ad una dettagliata descrizione della proprietà che le monache Clarisse avevano avuto in lascito da Pompeo Valentoni, dalla quale risulta non esservi né la chiesa, né alcuna fontana, ma soltanto nella parte soprastante una porzione della torre a confine con detta proprietà. |
 |
Santa Maria dell'Ilice o della Nova o dei Longobardi (sec.XIII?) Non abbiamo una datazione certa per questa piccola chiesa a navata unica e due porte d'ingresso che si trova su una propaggine all'estremità occidentale, probabilmente fuori le mura della città alla quale si accedeva da una porta d'ingresso detta delli Trivolisi, corrispondente al quartiere Critè/Capo delle Rose. La chiesa è tuttora affiancata da una strada che conduceva a valle e alle marine di ponente. La definizione 'dei Longobardi' con cui è attualmente chiamata le deriva dall'illustrazione dell'abate Pacichelli riportata nella descrizione di San Marco agli inizi del XVIII secolo. In documenti antecedenti fu sempre chiamata Santa Maria dell'Ilice o della Nova. Il primo appellativo si riferisce alla presenza di un albero di leccio, mentre per Nova si intende la buona novella dell'Annunciazione. Non sappiamo il motivo per cui la chiesa cambiò nome e devozione. Infatti oggi è dedicata al culto della Madonna del Monte Carmelo che risale al XVI secolo. La predetta dedicazione ad un culto mariano di origine longobarda non trova alcuna documentazione tranne la definizione del Pacichelli. |
 |
Chiesa di San Giovanni degli Amalfitani, oggi Museo Diocesano (sec.XII)
Di questa chiesa abbiamo un documento che ne attesta l'esistenza già nell'anno 1209. Si tratta di un atto di compravendita di un 'casalino' nell'area pubblica antistante la chiesa di San Giovanni degli Amalfitani. Il documento fa parte delle cosiddette Carte Latine dell'abbazia della Matina pubblicate dallo storico Alessandro Pratesi. La dedicazione della chiesa è indicativa dello stretto rapporto che esisteva tra San Marco e la repubblica marinara di Amalfi conquistata dai normanni nell'XI secolo. La facciata aveva un aspetto diverso e fu innalzata negli anni Trenta del Novecento. Gli elementi lapidei del rosone e del portale, pur se restaurati, rispettano le strutture originarie. La chiesa divenne nel Seicento sede della Congregazione dell'Immacolata che aveva come patrono San Giovanni Battista. Oggi è sede del Museo Diocesano e al suo interno conserva pregiate opere di argenteria tra le quali una preziosa croce astile con reliquie del 1308. |
 |
Chiesa di Santa Caterina (sec.XVI secolo) Attualmente adibita a sala convegni e auditorium la sua costruzione risale al XVI secolo e fu sede della potente congregazione dell'Immacolata, come attesta il libro contabile conservato nell'archivio privato della famiglia Selvaggi, redatto negli anni dal 1598 al 1603, quando la congregazione si trasferì nella chiesa di San Giovanni degli Amalfitani. Nel documento è scritto che le suppellettili furono lasciate nella chiesa, e tra esse quelle che tuttora vi si trovano e richiamano l'attenzione del visitatore sono gli stalli laterali del coro ligneo e il sovrastante pulpito. Dopo il trasferimento della congrega, l'edificio fu restaurato. Vi furono eseguiti almeno due interventi, uno nell'immediato con l'elevazione dell'edificio e con la creazione di un portale in pietra di mediocre fattura e con il rifacimento della torre campanaria. Un altro intervento riguardante l'interno fu eseguito nell'Ottocento a cura del barone Campagna priore della nuova Congregazione religiosa che aveva scelto la chiesa come propria sede. A quel periodo risale la grande tela, forse originariamente collocata sulla volta, raffigurante il Compianto del Cristo Morto, che ritengo sia da attribuire ad un pittore locale, Nicola Pagano. |
 |
Convento e chiesa di San Francesco di Paola (sec.XVI) Il convento di San Francesco di Paola, a cui più tardi si unì la chiesa omonima, nasce nel XVI secolo per volontà e con il contributo di alcune famiglie nobili. Probabilmente fin dall'inizio era un romitorio. Ancora nell'Ottocento, infatti, troviamo citate persone che prestavano assistenza presso l'Ospedale dei Poveri ubicato all'imbocco dell'attuale via Vittorio Emanuele, allora via San Francesco. La proprietà dei Minimi, grazie a donazioni e lasciti, si estese sia nella zona sottostante che a monte, raggiungendo i terreni che circondavano la torre. Certamente la famiglia Valentoni che era proprietaria di vasti territori fu la principale sostenitrice dei francescani di Paola. Il luogo in cui sorse il convento faceva parte del vasto comprensorio appartenuto all'abbazia della Matina con il nome di Santa Venere, che si estendeva dall'omonimo torrente fino alla Conicella. Probabilmente proprio nell'area in cui sorse il complesso francescano era ubicata la chiesa di Santa Venere citata in vari documenti facenti parte delle Carte Latine del Pratesi. Più tardi l'area prese il nome di Santo Stefano che conservò fino ai nostri giorni. Il seminario fu trasferito dalle cosiddette vecchie fabbriche del seminario, corrispondenti al palazzo Talarico all'imbocco di via Roma, presso l'area conventuale di San Francesco nel 1823 a seguito di una permuta effettuata con il Comune. La chiesa, come appare oggi, fu iniziata nell'Ottocento e completata nei primi anni del secolo successivo. |
 |
Sant'Antonio Abate (sec.XIII?) Prima ancora dell'esistenza di una chiesa con tale nome abbiamo notizie di un omonimo quartiere che delimitava a sud-ovest l'area denominata Motta. Il quartiere che conservò anche in anni recenti questo nome è descritto nella Platea delle Monache di Santa Chiara come parte terminale del paese, ai cui limiti si vedevano ancora vecchie muraglie e risultava privo di strada di accesso. Notizie sulla chiesa sono databili a partire dall'Ottocento, quando in un contenzioso tra due famiglie per l'utilizzo di un corso d'acqua, si fa cenno alla creazione di un alloggio per viandanti accanto alla chiesa. In dialetto il santo era chiamato Sant'Antuonu e la sua immagine con a fianco un porcellino farebbe pensare che il quartiere fosse originariamente destinato all'allevamento dei maiali. |
 |
Luogo Santo (sec.XIX) La chiesa come si presenta oggi fu costruita nell'Ottocento su progetto del canonico Salvatore Cristofaro, come egli stesso afferma nella Cronistoria di San Marco Argentano, in cui spiega l'origine di questo tempio destinato a custodire le reliquie dei Martiri Argentanesi. Sul luogo esisteva già una chiesetta eretta agli inizi del XVII secolo ormai andata in rovina, sorta a sua volta sui resti di altro edificio religioso. Il martirio di Dominata e dei figli Senatore, Cassiodoro e Viatore sarebbe avvenuto in prossimità delle cosiddette destre di San Nicola, un pianoro di fronte il nuovo tempio, dove stando sempre al Cristofaro, esistevano i ruderi di una cappella, dalla quale i corpi furono trasferiti in un'altra chiesa intitolata a San Senatore. L'impossibilità di raggiungere quei luoghi, per mancanza di un ponte sul Fullone, fu all'origine del trasferimento nel sito e nella chiesa che presero rispettivamente il nome di Luogosanto e di Santa Maria del Luogo Santo. Stando, però, ad una relazione del sindaco dei nobili Ignazio Gonzaga del 1692 i corpi dei Martiri furono trasferiti nella cattedrale e da qui trasferiti a Venosa per volere di Roberto il Guiscardo. Il vescovo di quella città, rinvenute le sacre reliquie nel 1693, le fece trasferire nella città di origine, ovvero San Marco, e qui furono custodite in parte nel Luogosanto e in parte nella cattedrale. In alcuni atti dell'Ottocento il Luogosanto risulta che fungesse anche da romitorio. Al suo interno alcuni dipinti del pittore Michele Lugo, riprodotti anche in immaginette votive, illustrano il processo e la condanna a morte dei detti Martiri. Nell'area immediatamente prossima al tempio cresce l'olivo leucocarpa dalle caratteristiche drupe bianche, introdotto, a quanto si può leggere su Internet, dai monaci basiliani per amministrare i sacramenti. |
 |
Grotta San Pietro (sec.XIII?) Una leggenda vuole che Pietro e Marco siano passati per le nostre zone e che a memoria di tale passaggio siano stati dati i nomi del principe degli apostoli ad una grotta, quindi ad una chiesetta, dalle quali in seguito avrebbe preso il nome un quartiere, oggi sottostante alla via Duca degli Abruzzi. La grotta che porta attualmente l'indicazione San Pietro si trova nella roccia sottostante il campanile della cattedrale, ma l'illustrazione di san Marco Argentano pubblicata sul volume dell'abate Pacichelli, con la denominazione di grotta San Pietro riporta un sito diverso, forse coincidente con il luogo dove oggi sorge l'omonima chiesetta La grotta oggi esistente, sottostante il campanile, è un vano ampio con volta a sesto acuto direttamente scavata nella roccia, di fronte all'ingresso la parete cieca presenta un piano che potrebbe aver avuto funzione di altare e sul lato destro tre piccole nicchie disposte a scala. L'intervento umano è evidente, ma è difficile stabilire quale possa essere stata l'originaria funzione di questo antro. La presenza a poca distanza di un arco a sesto acuto in blocchi di pietra arenaria, alla quale lo scultore Eduardo Bruno ha attribuito la funzione di porta cittadina, e l'esistenza di un'antica fontana prossima alla chiesetta, caratterizzano questa vasta area un tempo densamente abitata e servita dalla strada "Pie' la silica", così chiamata perché iniziava dalla vasta pianura sottostante al grande massiccio della Motta. |
 |
Chiesa bizantina contrada Prato (sec.X?) Prato è una contrada storica di San Marco Argentano. Era un vicus su sui il vescovo di Malvito vantava diritti. Era abitata da piccoli proprietari, monaci e pubblici funzionari, come risulta dai nomi e dalle funzioni, documentati in un atto di donazione di Roberto il Guiscardo all'abbazia della Matina e in atti confermativi dei successori del duca normanno. La contrada di indubbio interesse storico presenta una serie di grotte distribuite in varie zone, residui di manufatti cementizi e la testimonianza edilizia della presenza di una chiesetta di cui restano parte dell'abside e della parete destra. Un grosso manufatto cementizio, apparentemente di forma circolare, occupa la zona centrale interna. Le persone più anziane del luogo riferiscono che fino ad alcuni anni fa si celebravano a Prato festeggiamenti in onore di San Nicola. Salvatore Cristofaro nella Cronistoria riporta la notizia di un attentato compiuto contro i monaci dell'Abbazia per vendicare l'oltraggio commesso su una donna del luogo. Fino a qualche decennio fa (anni Settanta del Novecento) dal terreno emergevano resti di ossa umane, segno che la chiesa o il terreno circostante furono utilizzati per sepolture. |
 |
Mulino di mezzo (sec.XIV-sec.XVIII) È così chiamato per la sua posizione rispetto ad altri mulini, ma in documenti antecedenti è chiamato il Mulino della Corte (ducale). Nell'Ottocento troviamo che era di proprietà delle famiglie Sacchini-La Regina eredi della famiglia Fazzari, a cui appartenne. In verità i mulini sono due, di epoche diverse. Il più antico dovrebbe risalire almeno al XIV secolo, il secondo presenta caratteristiche decorative e strutturali tipiche del XVIII secolo. Il mulino dava anche il nome ad una piccola contrada chiamata Macchie del Molino. Tra le donazioni che Roberto il Guiscardo fece all'abbazia della Matina c'è il riferimento a tre mulini, uno dei quali appartenente alla stessa abbazia; non è escluso che il mulino di mezzo, per la sua posizione lungo il torrente principale, il Fullone, potesse essere uno dei tre. Difficile stabilire, comunque, se e quando esso fu modificato. Attualmente è proprietà della famiglia Veltri, un cui componente fu l'ultimo mugnaio che utilizzò l'impianto molitorio fino agli anni Sessanta del Novecento. |
 |
Il centro storico Oggi è così chiamato l'insieme degli edifici e delle strade di più antica formazione per distinguerlo dalle aree che hanno avuto uno sviluppo edilizio in tempi più recenti. Spesso per indicare l'intero centro urbano viene usata impropriamente la definizione ... (continua a leggere) |