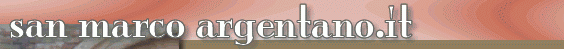 
| |
 San Marco Argentano e i suoi monumenti San Marco Argentano e i suoi monumenti

Vedi anche MONUMENTI DI SAN MARCO ARGENTANO | |

Un fermo immagine di una ripresa col drone realizzata su Youtube da "Trekking,
RC... and something more"
(Centro storico di San Marco Argentano)
|
|
Oggi è così chiamato l'insieme degli edifici e delle strade di più antica formazione per distinguerlo dalle aree che hanno avuto uno sviluppo edilizio in tempi più recenti. Spesso per indicare l'intero centro urbano viene usata impropriamente la definizione di borgo. San Marco nacque come "castrum" nel secolo XI in seguito allo spostamento da Scribla di Roberto il Guiscardo secondo lo storico Goffredo Malaterra o, secondo Amato di Montecassino, mandatovi dal fratello Drogone che vi aveva installato una struttura in legname su un'altura naturalmente fortificata. Da un punto di vista morfologico il luogo è un promontorio litico che si erge sulla vallata attraversata dal fiume Fullone. La vallata inizia dalla confluenza del torrente Santa Venere con il predetto fiume e si estende fino al territorio dove si trovano i resti di Scribla. L'altura, che si presenta come una roccaforte naturale, è chiamata la silica; la parte più alta è chiamata la Motta. La roccaforte è immediatamente visibile per chi proviene da Scribla. Su quest'altura Roberto il Guiscardo e i suoi uomini -alcuni cavalieri e sessanta fanti sclavi- si accamparono. Esattamente dove? Alcuni ritengono alla Motta, altri in una zona più a monte denominata Catuccio, dove il Guiscardo avrebbe fatto erigere la torre. Dalla Motta si controllava tutto il territorio circostante, mentre Catuccio non offriva nessun punto strategico, neppure con l'elevazione di una torre, dalla quale, come si può verificare ancora oggi, non si vedono le aree immediatamente a valle. La Motta, invece, oltre alla posizione strategica, risultava naturalmente difesa dal terreno fortemente scosceso dei versanti a nord (sulla vallata) e a occidente (sulla cosiddetta 'Vardara'). Prima di addentrarci nella ricerca di quale fu il primo nucleo abitato che diede origine al centro storico, dobbiamo chiederci se questo primo presidio ha lasciato tracce da un punto di vista urbanistico e se esso può essere considerato il nucleo del successivo sviluppo urbano. Gli edifici che chiudono la collina della Motta sul lato più esposto (quello su via Roma) per la loro disposizione suggeriscono l'idea di una fortificazione a cui ancora oggi si accede attraverso la porta di una torretta. Sia quest'area che un pianoro sottostante (dove in seguito sorgerà il duomo) presentano caratteristiche compatibili con un castrum ovvero un acquartieramento militare. Possiamo considerare quest'area il primo nucleo di formazione della città? Da un punto di vista strettamente urbanistico non sono rilevabili elementi di sviluppo intorno ad esso, ma il fatto che nell'area occupata dal Guiscardo sia sorto in seguito l'episcopio, rappresenta un passaggio di poteri che ha avuto senza dubbio un'influenza determinante sullo sviluppo cittadino. Prima di prendere in esame dove e come si sviluppò un primo nucleo abitativo è opportuno conoscere la morfologia del territorio. Morfologicamente il territorio si sviluppa lungo una collina che ha il suo culmine nella Conicella. Lungo questo percorso vi sono alcuni pianori, due dei quali nel corso dei secoli sono diventati piazze, unite da un crinale che crea due versanti corrispondenti ai centri abitati di più antica formazione. In quale di questi versanti si sviluppò il primo nucleo abitato? Anche in questo caso, prima di rispondere a questa domanda che trova quasi tutti concordi nel ritenere che fosse nel versante occidentale e in particolar modo nei rioni Santa Maria-Capo delle Rose, è utile fare riferimento ad alcuni documenti dell'epoca o di epoca immediatamente successiva, in cui si parla delle condizioni antropiche di queste aree. Il primo, alquanto generico, è il cosiddetto atto di donazione di Roberto all'abbazia della Matina, documento che tra i territori prossimi a San Marco individua quello più esteso che dal vallone Santa Venere si estende fino alla Conicella. Il territorio è chiamato Santa Venere dove è attestata la presenza di una chiesa e di sporadici proprietari di terreni con i rispettivi nomi. L'assenza di edifici e di abitanti ci dice che all'epoca della donazione, il 1065, esso non era ancora urbanizzato. Il secondo documento è un atto di vendita di un casalino. Nell'atto, datato 1209, viene specificato che esistono una chiesa dedicata a San Giovanni degli Amalfitani e una piazza. L'acquisto del casalino da parte di due coniugi e la presenza di un altro casalino, già oggetto di precedente acquisto, provano che siamo in presenza, a distanza di un secolo circa dal primo documento, di uno sviluppo urbano. Iniziato da chi? Certamente non dal Guiscardo e dalla prima moglie Alberada visto che nell'atto del 1065 non ci sono riferimenti a possedimenti diversi da quelli del vescovo di Malvito. Dobbiamo, quindi, supporre che il popolamento del territorio debba essere attribuito all'abbazia della Matina che di quelle terre era diventata proprietaria incontrastata, soggetta al solo vincolo papale. Se nel 1209 è documentata l'esistenza di una chiesa è presumibile che essa sia stata costruita nel secolo precedente considerando la presenza di piazza e casalini ed è altrettanto presumibile che il primo nucleo abitato sia quello sottostante ad essa che in documenti del Cinque-Seicento troviamo indicato col nome di quartiere del Crité. Un percorso, anch'esso sottostante alla chiesa di San Giovanni, adeguandosi alle curve di livello del terreno, lo congiungeva al quartiere di Sant'Antonio Abate. Esiste anche un terzo documento, un atto di compravendita di un terreno sul fiume Fullone, datato 1088, in greco. Traggo la traduzione e il commento dall'appendice di don Tonino Caruso ad una riedizione del Martiri Argentanesi di padre Francesco Russo. Il terreno, è scritto sul documento, "soggiace alla giurisdizione di San Marco, di fronte alla sua magnifica roccaforte". In un rigo successivo leggiamo che il compilatore dell'atto era un presbitero di Cassano, di nome Nicola, "archivista della rocca di San Marco". Il documento ha la sua importanza da un punto di vista urbanistico in quanto, come fa rilevare don Tonino Caruso, con il termine greco castellion in una parte del documento l'estensore sembra indicare l'intero abitato di San Marco, in un'altra sembra che castellion e San Marco siano due entità distinte. Siamo nel 1088 e il terreno ricade sotto la giurisdizione di San Marco. Senz'altro non della diocesi e, non essendo dipendente da quella di Malvito, dobbiamo pensare alla giurisdizione esercitata da Ruggero Borsa figlio di Roberto il Guiscardo e di Sichelgaita o dall'abbazia della Matina. In un quarto documento delle Carte Latine del 1100 Ruggero conferma all'abbazia possedimenti e diritti riguardanti due chiese, quella di Santo Stefano (in atti precedenti di Santa Venere) e quella di San Nicola, i cui territori sono vicini alla civitas di San Marco. Sappiamo, dunque, che una civitas con potere giurisdizionale esisteva negli ultimi anni dell' XI secolo e che i terreni appartenenti alle chiese di Santo Stefano e di San Nicola erano vicine ad essa. Non sappiamo, però, dove fosse ubicato l'agglomerato urbano con i suoi abitanti. L'ipotesi che esso fosse nel predetto quartiere del Critè è molto probabile, essendo le due chiese poste ai lati di esso, la prima nell'area ove oggi sorge la chiesa di San Francesco, la seconda dove sorge il duomo. Quale fu il successivo sviluppo? L'area più a monte, dove fu eretta la torre nel XIII o XIV secolo, fu delimitata da mura e da una porta come risulta dalla Platea delle Clarisse e da una deliberazione consiliare del 1862, con la quale si decide l'abbattimento della porta. Sotto la torre si sviluppò, sul versante settentrionale, il quartiere ebraico, che comprendeva anche l'abitato in seguito chiamato Casalicchio o Casaletto. Il quartiere della torre era la periferia estrema dell'abitato. Sul versante occidentale era collegato alle contrade Santo Stefano, Santa Venere e Sant'Opoli. Al di fuori delle mura, oltre la porta Santomarco, in seguito chiamata Porta Vecchia, si raggiungeva il pianoro dove nel 1320 sorse il convento dei Minori di San Francesco e, proseguendo lungo la contrada Pellari, la valle del Crati. In un atto decurionale del 1858 la strada della Riforma era ancora chiamata strada consolare. Da quanto sopra emerge che non esisteva il classico borgo medievale con un agglomerato urbano sviluppatosi intorno ad un centro di potere, laico o ecclesiatico, ma il territorio era suddiviso in piccoli quartieri sorti in luoghi distanti e indipendenti l'uno dall'altro. Uno di essi, dotato di autonomia amministrativa, era chiamato San Marco. La decadenza dell'abbazia della Matina comportò la graduale perdita dei suoi possedimenti, in alcuni casi forse usurpati per mancanza di puntuali delimitazioni. Alla fine del Seicento furono dati in fitto a Torquato Falangola per una cifra molto inferiore al loro valore, come riporta Salvatore Cristofaro nella Cronistoria. La nascita di un borgo unico si deve alla Chiesa e alle ricche famiglie entrate nelle grazie dei Sanseverino per meriti o legami parentali, attraverso la realizzazione di edifici civili e religiosi e la creazione di nuovi quartieri. Ad esempio l'istituzione del seminario, la costruzione di un ospedale dei poveri, la fondazione di un convento dei Minimi e di un monastero femminile, furono all'origine di nuovi assetti urbanistici, rispettivamente nell'area della Motta, a confine con il quartiere popolare di Santo Pietro, nell'area sottostante la torre sul versante della piazza, lungo il percorso che univa le due piazze per quanto riguarda il monastero delle Clarisse. Tali realizzazioni comportarono lasciti e donazioni, che accrebbero il patrimonio di ciascuna istituzione. Tale patrimonio si componeva di nuovi edifici e terreni, dati in affitto ad artigiani e piccoli proprietari. Dalla Platea delle Clarisse scopriamo il vasto patrimonio che negli anni il monastero aveva accumulato. Tra la fine del Seicento e il Settecento possiamo già parlare di una città definita urbanisticamente che corrisponde all'attuale centro storico. L'ultimo assetto urbanistico, destinato ad aprire il vecchio borgo ai commerci, avvenne tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento con l'apertura di nuove arterie e la realizzazione di edifici destinati ad abitazione, attività artigiane e commercio. Molte delle vecchie strutture furono integrate adeguandole alle nuove esigenze, alcune furono abbattute e altre utilizzate con fini diversi. San Marco Argentano, 3 marzo 2025 Paolo Chiaselotti Carte Latine... "Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini
di Alessandro Pratesi, pubblicato da Biblioteca Apostolica Vaticana, 1958"
|